Zoo di Venere (Lo) - Zed And Two Noughts (A)
|  |  |  |  |  |  |
| Regia: | Greenaway Peter |
|
| Cast e credits: | 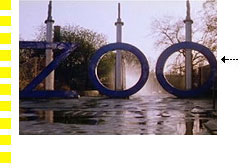
Soggetto e sceneggiatura: Peter Greenaway; fotografia: Sacha Vierny; musiche: Michael Nyman; montaggio: John Wilson; scenografia: Jan Roelfs; Ben Van Os; interpreti: Andréa Ferréol (Alba Bewick), Brian Deacon (Oswald Deuce), Eric Deacon (Oliver Duece), Frances Barber (Venere), Joss Ackland (Van Hoyten), Jim Davidson (Joshua Plate), Agnes Brulet (Beta Bewick), Guusie Van Tilborgh (Caterina Bolnes), Gerard Thoolen (Van Meegeren), Ken Campbell (Stephen Pipe), Wolf Kahler (Feliphe Arc En Ciel); produzione: British Film Institute, Artificial Productions, Film Four International; distribuzione: Ventana; origine: Gran Bretagna-Olanda, 1986; durata: 115’. Vietato 14 |
|
| Trama: | Un incidente d'auto, provocato da un cigno che si abbatte sul parabrezza di una Ford-Mercury, causa la morte di due giovani donne e il ferimento della terza, Alba, che si trovava alla guida e che si vede amputata una gamba dal chirurgo-pittore falsario Van Meegeren, il quale le amputerà in seguito anche la seconda, perché la donna risulti copia vivente dei suoi quadri stravaganti. L'incidente lascia vedovi due entomologi gemelli ex siamesi, che lavorano per uno zoo, filmando i tempi e le fasi di disfacimento di animali morti. I due mutano presto l'odio per la sopravvissuta Alba in una passione indefinibile, che frutterà una coppia di gemelli unimadre e bipadre, i quali dopo il "sereno" suicidio di Alba e in esecuzione delle sue disposizioni, verranno però affidati a un terzo uomo, Feliphe Arc-en-ciel, (sempre in bianco come un cigno e lui pare privo di gambe), mentre i due bis-vedovi si suicideranno altrettanto "serenamente" di fronte a una telecamera predisposta a filmarne la decomposizione. |
|
| Critica (1): | Il giardino e lo zoo: i film di Peter Greenaway partono dal presupposto di una natura sotto chiave, sterilizzata e fissata in un ordine classificatorio. Il seicentesco parco di Compton House si mimetizza con la campagna, eppure è un luogo delimitato, il simulacro di una naturalità in cui si rispecchia il senso di realizzazione, di armonia, di controllo sulla realtà di una classe al potere senza ostacoli e nemici. Perciò non c'è rottura nel paesaggio; lo sguardo dei signori si estende uniforme a tutto il mondo circostante, se non fosse che proprio l'ansia di autorappresentazione, che si traduce nei quadri commissionati a Mr. Neville, finisce per mettere in luce tanta tranquilla opulenza come pura idealizzazione. Infatti la mano sicura e veloce del pittore, le proporzioni che l'accurato studio della prospettiva vorrebbe esaltare, il carattere di istantanea degli scorci, realizzati secondo una rigida programmazione, quasi che nulla possa turbare l'immobile trasparenza di quel «paesaggio con figure», nascondono il modificarsi delle situazioni, il continuo patteggiamento fra i soggetti e la non-neutralità dello stesso osservatore. Tutto ciò che viene dato come natura in effetti è linguaggio, codificazione, e il film coglie mirabilmente la sospensione di un trompe-l'oeil tra fissità e movimento, tra oggettività e degenerazione mostruosa. Nello Zoo di Venere, fin dai titoli di testa, che hanno l'opalescenza della luce al neon, si capisce che la dimensione del film è lontana dai contorni netti, dal geometrismo della precedente opera di Greenaway: qui non ci sono esterni ario-
si, ma interni illuminati a intermittenza dai flash di macchine fotografiche; non c'è l'immobilismo artificiale delle forme, ma il rapido degradarsi (con la tecnica del cinema d'animazione) dell'architettura dei corpi. L'idea di registrare la putrefazione degli animali fa tutt'uno con quella più generale di lavorare sui cascami moderni del mito, di mostrare il decomporsi e l'ibridarsi dei linguaggi e la perdita di profondità del reale. In questo senso il giardino zoologico, come universo proiettivo in cui l'uomo ha devitalizzato la natura e l'ha trasformata in un teatro per le proprie fantasie, è il catalizzatore di una babele di immagini: documentari scientifici e citazioni mitologiche (il cigno di Leda, l'unicorno), animali dal vero e gigantografati nella pubblicità della Esso o della Camel.
Ogni personaggio ha il suo bestiario: il direttore dello zoo è ossessionato dall'idea di eliminare tutti i suoi ospiti col mantello bianco e nero; la prostituta Venere di Milo esercita il mestiere fra le gabbie e seduce i clienti con racconti pornografici ambientati fra gli animali, in attesa che qualcuno la metta in contatto con un editore. Per tutto il film aspirazioni artistiche e vendita, manipolazione, mutilazione di corpi vanno insieme in un connubio degradato, dove domina l'inibizione del sesso e una persistente necrofilia. Il losco chirurgo Van Meegeren, il cui nome riprende quello di un famoso falsario di Vermeer, coinvolge i suoi pazienti nella creazione di tableaux vivents che ripetono i quadri del pittore olandese: la sua predilezione per il calco dei dipinti si accompagna a quella per le amputazioni sui viventi, in un'evidente analogia tra l'atto di riprodurre e quello di ridurre. L'animalità, intesa in generale come espressione non soggetta alle categorie – e alle mostruosità – del «culturale», è un pericolo da esorcizzare: il sesso è perciò sempre abbinato dai personaggi a immagini di morte e di disfacimento fisico (la descrizione compiaciuta dei batteri che ci si scambia durante un bacio; la storia della puttana senza gambe e la disquisizione grottesca sulla forma della sua bara; la particolare attenzione riservata alle lumache, che alla fine invadono letteralmente lo schermo e di cui si dice, a titolo di merito, che sono ermafrodite e aiutano il mondo a marcire).
Il film suggerisce che da Darwin a Mengele, adombrato nel dottor Van Meegeren, c'è un'unica linea di congiunzione: il vivente, debitamente classificato, si è trasformato in materiale a disposizione per modelli astratti, speculari solo a se stessi, e da qui – il passo è breve – per esperimenti distruttivi su corpi divenuti ormai soltanto un insieme di parti anatomiche, di nomi, di tassonomie, quasi un ingombrante residuo rispetto al linguaggio che li definisce. Lo scienziato, come il pittore di Compton House, convinto assertore dell'oggettività, costruisce il fantasma di un osservatore esterno, sopra le parti, e congela il divenire in tavole genealogiche, in quadri statici. Mr. Neville non percepisce il montaggio sequenziale dei suoi disegni, cioè l'intrigo che soggiace alla presenza o assenza di oggetti, di cui alla fine egli stesso è la vittima. Per lui infatti la visione prospettica equilibra la composizione e in un certo senso la eternizza; egli è alla ricerca di un'immagine senza tempo che esorcizzi l'angoscia della morte.
Per i due fratelli zoologi Oliver e Oswald Deuce la realtà esiste invece ormai solo come reperto; studiano difatti dei cadaveri. Il loro interrogativo di partenza sul mistero della vita, sulla concatenazione accidentale degli eventi (la ricerca prende le mosse dall'incidente in cui sono perite le mogli), sulla trasformazione nel tempo delle cose, viene ricondotto a quello basilare su che cosa separa un istante dal successivo. Non li aiuta in questo la visione di un documentario scientifico in otto parti – tante quante le tappe della selezione naturale stabilite da Darwin – che racconta l'evoluzione. A quella finzione contrappongono simmetricamente la registrazione del processo di decomposizione di organismi viventi, dai più elementari, la mela, ai più complessi, i mammiferi. Da un lato cioè rifiutano le «storie» che la scienza sovrappone al caos della vita per ridargli una direzione e uno scenario (in questo ordine presunto è la regola stessa dello zoo, che i due fratelli infrangono liberando gli animali dalle gabbie); dall'altro vorrebbero depurare il reale dall'accidentalità, piegarlo a uno svolgimento a senso unico, controllabile nella sua totalità. La decomposizione appunto, ricostruita nella rapida successione di fotografie scattate a intervalli regolari, fornisce un'immagine conclusa, ontologica, estrema sul piano concettuale oltre che su quello visivo; infatti la morte, che nei disegni di Neville era il fuoricampo, l'antagonista, ma anche l'elemento occultato nelle linee troppo nette e nei dettagli maniacali, quasi che il pittore volesse esaltare la pienezza della realtà di fronte allo spettro del disfacimento, è qui al centro dell'inquadratura, che viene privata così di ogni interna vibrazione, di ogni elemento di tensione drammatica. La presenza della morte cancella il racconto; la ripetizione del processo di decomposizione non suscita alla fine né angoscia né orrore, semmai lascia lo spazio a margine per un umorismo demenziale (ben espresso dalla musichetta in stile slapstick che accompagna le immagini accelerate di animali in putrefazione).
Tocchiamo così l'estremo limite di una scienza ormai indifferente alla realtà fenomenica, che vede letteralmente dissolversi il suo oggetto e che in definitiva non postula neppure il momento dell'interpretazione, ovvero la funzione di un osservatore. I due fratelli infine rinunciano a tale ruolo, suicidandosi e offrendo il proprio cadavere alle macchine fotografiche, in modo da lasciare una documentazione che essi stessi non potranno mai vedere. Fortunatamente la natura, riappropriandosi attraverso migliaia di lumache dello strano set creato dai due, mette fine al mostruoso esperimento.
Nell'illustrare il corto circuito dei modelli di conoscenza e rappresentazione della realtà, Greenaway adotta un tono leggero, una narrazione ricca di paradossi, niente affatto dimostrativa. Già il
divertito barocchismo dei dialoghi riesce a evitare al film la grevità di un apologo, ma poi la «storia» è tutta un calembour, intessuto di riferimenti colti e di citazioni da bordello, di bizzarre analogie e di improvvisi rovesciamenti. Si pensi al ritornare di certi numeri (i ventisei quadri di Vermeer, le ventisei lettere dell'alfabeto, i ventisei figli che Alba, l'amica dei due protagonisti, vorrebbe avere) o di determinati colori (il bianco e nero delle zebre, dei cani dalmata, delle mutandine striate che indossa l'assistente di Van Meegeren). Il regista ama giocare con le classificazioni, inserendo continuamente sottotesti con il gusto dell'enciclopedia più che del romanzo (del resto, fra i suoi film quello che preferisce è The Falls, inedito in Italia, che è al tempo stesso un compendio scientifico e una raccolta di interviste a sopravvissuti di un'immaginaria catastrofe atomica). Di fondo a questa predilezione per le serie e per le loro combinazioni c'è naturalmente lo scetticismo riguardo alla legittimità del racconto a intreccio. Quest'ultimo nello Zoo di Venere, ridotto all'osso, consiste nel perfezionamento di una simmetria che annulla lo svolgimento del film medesimo e che si risolve, con una precisa funzionalità anche narrativa, nella morte dei protagonisti. Di partenza abbiamo dunque i due fratelli Deuce (deuce =due) privati delle rispettive metà, i quali si accoppiano con Alba, una donna con una gamba sola, ben disposta però a farsela tagliare per spirito di simmetria. Ne nascono dei gemelli (dichiarazione della madre: «Due entrarono e due uscirono»); la donna in seguito respinge i due uomini e va in cerca di un proprio omologo maschile, anch'egli mutilato agli arti inferiori e, si potrebbe aggiungere, metaforicamente privo dell'attributo sessuale. Trovatolo, muore. I due fratelli intanto, rimasti senza la figura-filtro femminile, vanno scoprendo le rispettive affinità: rivelano di esser stati in origine gemelli siamesi, si tingono i capelli per raggiungere la più completa somiglianza e si fanno confezionare vestiti che li uniscano come in un solo corpo, col mito forse dell'ermafrodito. Divenuti l'uno il doppio dell'altro, si suicidano.
Specularità come sospensione e dissolvimento del senso: è evidente che dal gioco di specchi, che trasforma i film di Greenaway in scatole cinesi, non si esce. Così è anche per gli animali che i due fratelli liberano dalle gabbie, costretti a vagare spaesati e impauriti per il recinto dello zoo. Eppure sono loro a dare al film le immagini più belle, quelle in cui si coglie un elemento di distorsione, di ribellione all'impianto scenografico dell'inquadratura: si pensi all'idea di accostare un rinoceronte a una fontana neoclassica. È questa corrente che si esprime sul piano visivo, in antitesi al carattere univoco e nichilistico del discorso del film, a sottrarre lo Zoo di Venere alla perfezione delle cose morte. È poi la lezione di Veermer, che il regista ricostruisce filologicamente in almeno due quadri, «Ragazza con cappello rosso» e «Signora alla spinetta», e che comunque fa da riferimento generale per la fotografia di Sacha Vierny, il quale, lavorando abitualmente con Resnais, conosce molto bene le qualità del pittorico nel cinema.
Di fronte ai tranquilli interni domestici ritratti dal pittore olandese si prova fin da subito un senso di disagio, l'impressione che qualcosa sfugga al controllo nonostante l'evidenza della scena, raramente con due personaggi, spesso con uno solo. A un esame più attento si scopre che al carattere mansueto dei volti e alla quotidianità dei gesti si oppone una precisione quasi violenta nel disegno di mobili e suppellettili, che impongono a chi guarda nuovi punti di focalizzazione, aprendo in virtù del cesello e del cromatismo prospettive
vertiginose nella superficie del quadro. Si tratta in effetti di una rottura del narrativo, mantenuta però a livello subliminale: l'istante viene fissato da Veermer con una sensibilità che oggi diremmo fotografica, ma c'è tensione negli elementi della composizione, quasi che l'«istantanea» non li bloccasse veramente.
Questa stessa polisemicità si ritrova nelle inquadrature di Greenaway, il cui immobilismo è spesso ragione di sottile inquietudine per lo spettatore, per la presenza di indizi dell'azione non ben interpretabili nella loro fissità (indicano un fatto concluso o in via di preparazione?). E quando il movimento c'è – dei personaggi o della camera – non è mai scindibile da una cornice architettonica o scenografica che lo «ghiaccia» e lo rende apparente. Da pittore, quale a sua volta è, Greenaway coglie il lato opaco della verosimiglianza. Non cade nell'inganno di cercare una nuova trasparenza a monte dei linguaggi, ciò che è compito dei filosofi e prerogativa di registi ansiosi di distruggere il cinema. A lui interessa il venir meno della presunta oggettività, il limite oscuro e invalicabile che in un modello di rappresentazione sta fra l'essere e il divenire.
Lodovico Stefanoni, Cineforum n. 259, 11/1986 |
|
| Critica (2): | Introduzione di Peter Greenaway al film
Nonostante ci siano numerose matrici visive all'origine di Lo Zoo di Venere se ne possono facilmente riconoscere tre: un video, una scimmia e una fotografia prestata.
Il video è un filmato di tre minuti che mostra, in accelerazione, la decomposizione di un topo comune, presentato nella trasmissione Horizon della BBC. Grazie allo scorrere delle immagini si vedevano i vermi attaccare, tutti assieme, il cadavere e divorarlo, come un'orda. L'operatore nutriva l'ambiziosa speranza di poter filmare un giorno la decomposizione di un elefante.
La scimmia viveva allo zoo di Rotterdam e aveva una sola gamba. L'animale era stato incatenato in un cortile. La catena si era incrostata alla gamba e l'unico modo di impedire all'infezione di estendersi era stata l'amputazione. In alcuni momenti, quando l'animale si arrampicava e si dondolava nella gabbia, sembrava che l'assenza della gamba non costituisse nessun handicap. La sua invalidità sembrava essere vittoriosamente superata.
E la fotografia mi era stata generosamente prestata nel 1978 perché l'utilizzassi in un film enciclopedico intitolato The Fallé: mostrava una donna dal sorriso fiducioso, ritratta tra i fratelli Quai, gemelli, identici, eleganti ed enigmatici, marionettisti e cineasti i cui metodi di animazione cinematografica non erano cosi lontani dalle idee di condensazione del tempo che ci avevano permesso di vedere come i vermi divorassero la carcassa del topo.
Con diversi gradi di manipolazione, consci e non, queste tre matrici visive primarie sono state fuse in uno script che – dal momento che le cose migliori vanno per tre – permetteva uno sguardo d'insieme sul trauma del lutto e il fascino della putrefazione; offriva un trampolino per mostrare, senza dare giudizi, la relazione ostinatamente dubbiosa fra l'uomo e gli animali; e presentava una nuova occasione per giocare con le tassonomie – in uso, in disuso, completamente inventate, improbabili, impertinenti, impossibili – le Otto tappe della selezione Naturale di Darwin, i sette giorni della Genesi, il Pantheon greco, le ventisei lettere dell'alfabeto, i numeri in diminuzione dei quadri autenticati di Vermeer, e cosi via... Il maestro delle cerimonie dell'aspetto visivo del film doveva essere Vermeer, manipolatore abile e profetico delle due componenti essenziali del cinema: la frazione di secondo dell'azione e il dramma rivelato dalla luce. Non si può provare che la «Caitière» di Vermeer sia un quadro che rappresenta un ventiquattresimo di secondo di tempo del diciassettesimo secolo, esposto af:8, ma la direzione della luce è certa: viene sempre dalla sinistra dell'immagine, da una fonte situata a un metro e quaranta da terra. L'intenzione di conservare rigorosamente questa regola ne Lo zoo di Venere è in buona parte venuta meno a causa degli ambienti naturali e dell'abitudine alla libertà degli animali, ma lo spirito è stato conservato. L'omaggio a Vermeer nella composizione, nei gesti, nei dettagli plastici è frequente e senza scrupoli. La donna di Vermeer, Catarina Bolnes, è presente nelle sembianze della «Donna dal Cappello Rosso». Cosi come il principale falsario di Vermeer, van Meegeren, l'uomo che riuscì a convincere l'Europa (e Goebbels) che esistevano più di ventisei Vermeer autentificati con certezza.
In corrispondenza con il contenuto, il principale processo di composizione, la «gemellarità» e la «simmetria». Fatti, finzioni, mitologie e recite apocrife sui gemelli sono di una ricchezza illimitata: due di ogni cosa, ricerca dell'altra metà, errori di identità, immagini allo specchio, sostituzioni, doppio, linee laterali, cloni. Non mancano certo intrecci, commedie, soggetti e saggi su questo argomento. La coppia archetipo dei gemelli, Castore e Polluce, i gemelli astrologici, nati da un uovo prodotto dall'unione di un cigno e di un dio, è il fulcro di Lo zoo di Venere, i fratelli Oliver e Oswald Deuce, le due lettere O, i due zeri di Zoo, riuniti per darsi in spettacolo.
E i fratelli abitano in uno Zoo. Si potrebbe dire, oggi, che tutti gli animali vivono negli Zoo, sia esso il Regent's Park di Londra o una riserva in Nigeria; quello che rimarrebbe da discutere forse è la qualità dello Zoo. Grazie al viaggio del Beagle, alla fine del cavallo da tiro, ai progetti attualmente allo studio per abbandonare la terra e alla nostra attuale e dubbia passione per l'ecologia, la nostra relazione con gli animali è drammaticamente cambiata nel corso degli ultimi cento anni; ma il senso di responsabilità è migliorato? E ci siamo noi assunti da una nuova responsabilità? Cosa ne è delle Sirene, delle Sfingi, dei Centauri, del Minotauro, dei Lupi-mannari, dei Vampiri e di quello Zoo proliferante di ibridi contemporanei? Se uno dei genitori era un animale che oggi ci è familiare dietro le sbarre di uno Zoo, che era l'altro? Gli animali sono forse come incidenti di automobile: delle catastrofi naturali o dei semplici incidenti - bizzarri, tragici, grotteschi ormai imprigionati in uno scenario da un ingegnoso dicitore di storie, tale M. C. Darwin? La Venere classica la Eva biblica? Se la durata dell'evoluzione sulla terra è rappresentata da un anno di 365 giorni, e se l'uomo ha fatto la sua apparizione alle 8 di sera del 31 dicembre, la donna è arrivata esattamente 8 ore dopo? Adamo era un gemello? E, in questo caso, che ne è stato di suo fratello? La zebra è un cavallo bianco con le strisce nere, o un cavallo nero con le strisce bianche? Il cinema é un mezzo di espressione troppo ricco per lasciarlo ai narratori di storie.
Dal press-book del film, in Cineforum n. 259, 11/1986 |
|
| Critica (3): |  |
|
| Critica (4): |  |
 | |
 |  |
|
 indica che il link è esterno al web comunale
indica che il link è esterno al web comunale
