Ora dei forni (L') - Hora de los hornos (La)
|  |  |  |  |  |  |
| Regia: | Solanas Fernando E. |
|
| Cast e credits: | 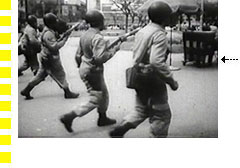
Sceneggiatura: Octavio Getino e Fernando E. Solanas; fotografia: Juan Carlos Desanzo; suono: Octavio Getino; assistente generale: Gerardo Vallejo; sono state utilizzate scene dei seguenti film: Tire die di Fernando Birri, Mayoria absoluta di Leon Hirzman, Il cielo e la terra di Joris Ivens; nonché frammenti d’immagini da Faena di Humberto Rios e da spettacoli del gruppo teatrale Frankestein; hanno collaborato alla realizzazione del film – dichiarano Solanas e Getino: «compagni operai, contadini, studenti, militanti rivoluzionari»; sottotitolo del film: "Notas y testimonios; sobre el neocolonialismo, la violencia y la liberacion"; produzione: Gruppo Cine Liberacion, Buenos Aires; distribuzione: San Diego cinematografica; origine: Argentina, 1968; titoli delle tre parti: Neocolonialismo y violencia (durata: 95'); Acto para la liberacion (120'); Violencia y Liberacion (40'). |
|
| Trama: | Sottotitolo: Appunti e testimonianze sul neocolonialismo, la violenza e la liberazione. Celebre documentario in tre parti (Neocolonialismo e violenza, 95’ divisi in 13 capitoli; Atto a favore della liberazione, 120’ articolati in due sezioni e 22 capitoli; Violenza e liberazione, 45’ divisi in 12 capitoli) sull’Argentina e la sua storia. |
|
| Critica (1): | "Il problema argentino è essenzialmente politico. Per non essere colonia, ci resta solo una possibilità: dare il potere al popolo". (Peron)
"Ogni nostra azione è un grido di guerra contro l’imperialismo e un clamore per l’unità dei popoli contro il gran nemico dei genere umano: gli Stati Uniti". (Che Guevara)
"Se dobbiamo compromettere tutti nella lotta per la salvezza comune, non vi sono mani pulite, non vi sono innocenti, non vi sono spettatori. Tutti ci sporchiamo le mani nei pantani della nostra terra e nel vuoto dei nostri cervelli. Ogni spettatore è un vigliacco o un traditore". (Frantz Fanon)
La hora de los hornos è composto di tre parti che durano complessivamente 4 ore e 20'. Questo film-saggio, il primo del genere girato in Argentina, riguarda i problemi nazionali e la Liberazione. Ha richiesto due anni di lavoro. Gli autori, durante le riprese, hanno percorso oltre 18.000 km. in Argentina. per documentare, nei punti più diversi, oltre 180 ore d’interviste. La maggior parte dei film è stata ripresa in 16 mm. e posteriormente ampliata. Il lavoro si è svolto clandestinamente, così come l’attuale situazione argentina impone.
Prima parte: Neocolonialismo e violenza
Dedicato a Che Guevara e a tutti coloro che caddero nella lotta per la Liberazione Iberoamericana.
Consta di un prologo sul’"in sé" della situazione argentina: la sua dipendenza, e di tredici parti i cui titoli sono: La storia; Il Paese; La violenza quotidiana; La città porto; L’oligarchia; Il sistema; La violenza politica; Il neorazzismo; La dipendenza; La violenza culturale; I modelli; La guerra ideologica; L’opzione.
L’Argentina così come il resto dei paesi latinoamericani, vive di tutti i mali generati dall’oppressione imperialista e dalla dipendenza. La violenza che si esercita sul popolo è quotidiana, assai ben simulata e non ha bisogno di manifestarsi in forma esplicita, in quanto "è" potenzialmente. Le sue conseguenze sono la fame, l’analfabetismo, l’alienazione. la distruzione degli autentici valori nazionali. La violenza è la pseudo Pace, il cosiddetto Ordine, la così chiamata Normalità. L’uomo latino-americano non può scegliere un modo di vita, né una morte vera e propria. Vita e morte sono rette da codesta violenza quotidiana. Solo ribellandosi l’uomo argentino e latino-americano potrà recuperare la sua esistenza.
Seconda parte: Atto a favore della liberazione
Dedicato al Proletariato Peronista, fautore della coscienza nazionale degli argentini.
Il film, oltre a possedere valori specifici, vuol essere elemento provocatore ed un atto a favore della Liberazione.
Prima della proiezione verranno distribuiti dei manifestini riproducenti l’Ordine del Generale San Martin dell’anno 1819, con il quale il popolo veniva esortato a combattere per la liberazione. Si ascolteranno marce rivoluzionarie. Negli Intervalli un commentatore dirigerà il dibattito.
Un’avvertenza sottolinea l’atmosfera dell’atto: Ogni spettatore è un vigliacco o un traditore (Frantz Fanon).
La prima parte dei film s’intitola: Cronaca del peronismo (1945).
In essa si analizza criticamente la vita nazionale durante i dieci anni che, per le classi sociali sfruttate, significarono la prima irruzione nel processo politico e nella lotta per il potere popolare. L’analisi contempla Il Movimento Peronista alla luce delle limitazioni che in quel momento erano proprie della società argentina e dei paesi vittime della stessa dipendenza. Il Movimento viene esaltato come il preambolo di quello che oggi chiamiamo il gran motore della storia: il Terzo mondo.
Si divide in dieci parti: Il 17 ottobre; Pseudosinistra e peronismo; Il peronismo al potere; La crisi del potere peronista; Il 16 giugno 1955; Il 31 agosto; La sconfitta nazionale; La festa dei gorilla; Le violenze della rivoluzione liberatrice; Riflessioni per il dialogo.
La seconda parte s’intitola: Cronaca della Resistenza ed è la descrizione delle lotte sostenute dal proletariato argentino nel periodo che il film definisce Decade della violenza (1955-1966). Ai dati si susseguono informazioni, interviste, analisi critiche delle azioni più significative della Resistenza. Nelle Interviste si ascoltano tanto le voci dell’anonimo militante metallurgico, quanto quella dei Segretario Generale della Centrale Operaia. Il film si compone delle seguenti parti: Prologo; La spontaneità; La clandestinità; Cronaca 1955-58; I sindacati; Cronaca 1959; I settori medi e l’intellettualità; Cronaca 1960-66; L’occupazione delle fabbriche; La limitazione della spontaneità; La guerra oggi; Introduzione al dibattito.
L’atto si conclude con la fine dei dibattito; saranno quindi i presenti a risolvere quando porvi termine.
Terza parte: Violenza e liberazione
Dedicato all’uomo nuovo che sorge da questa guerra di Liberazione
Anche questa terza parte del film è un atto a favore della Liberazione. È lo studio di testimonianze, lettere, interviste, relazioni sulla violenza come forma di Liberazione e costituisce "un momento aperto" che consente l’inserimento di nuovi brani, nuove lettere, nuove testimonianze di militanti. È destinato anch’esso al dibattito. Il film si chiude su una sequenza nella quale l’immagine e la Marcia La Hora da Los Hornos si fondono per convertire la Sintesi in una proposta d’apertura.
I titoli sono: Una vecchia storia di violenza; Lettere di militanti: Il tranello della legalità; L’impunità; Un militante intervista Jullo Troxier; Lettera: L’atteggiamento; Le vittime; Lettera: La guerra; Il nazionalismo rivoluzionario: Intervista a Juan José Hornandez Arregui; Lettera letta da un commentatore: La legalità della nostra violenza; Spazio aperto per nuove lettere, per nuovi appunti, per nuove testimonianze; Canto finale: La violenza come liberazione. 
SIGNIFICATO DEL FILM
Il popolo di un paese neocolonizzato come il nostro, non è padrone della terra sulla quale vive, né delle idee che gli vengono inculcate: non è sua la cultura dominante, al contrario, ne è la vittima. Solo possiede coscienza nazionale e la sua unica possibilità è la capacità d’essere sovversivo. La ribellione è la sua maggior manifestazione di cultura. Conseguentemente l’unico ruolo che possono assumere gli intellettuali è quello di unirsi a codesta ribellione per testimoniarla e approfondirla.
In Latinoamerica non v’è più posto per spettatori né per innocenti. Gli uni e gli altri sono complici dell’imperialismo. Ogni attività intellettuale che non serva alla lotta per la Liberazione Nazionale, è facilmente digerito dal nemico e assorbita dal gran pozzo nero che è la cultura del Sistema.
Il nostro impegno, come uomini di cinema e come appartenenti ad un paese in stato di dipendenza, non scende a compromessi con la Cultura Universale, né con l’Arte, né con l’Uomo in astratto. Noi sentiamo, anzitutto, un impegno per la liberazione della nostra patria, e dell’ uomo in concreto che è, in questo caso, l’argentino e il Latinoamericano.
A differenza delle grandi Nazioni, nel nostro paese l’informazione non esiste. Stagna una pseudo-informazione che i neocolonialisti usano abilmente per occultare al popolo la realtà e negargli di esistere. Ricercare informazioni, produrre testimonianze è la base per rivelare la Verità, e assume, in Latinoamerica, importanza rivoluzionaria.
Un cinema sorto per servire la causa della liberazione non è destinato a spettatori di cinema, bensì ai formidabili attori di questa gran rivoluzione continentale. Ha come scopo l’essere utile alla lotta contro l’oppressione, perciò è, come la verità nazionale, un cinema sovversivo. Esso raggiungerà pochi attivisti e militanti, ma per mezzo loro potrà trascendere a strati sociali ben più vasti. La sua estetica è conseguente alla necessità di questa lotta, così come alle possibilità che la stessa gli offre.
La hora de los hornos è, anzitutto, un atto a favore della Liberazione, poi un film. È un atto antimperialista che non ammette innocenti, spettatori o complici. È un film aperto al dialogo e all’incontro delle volontà rivoluzionarie. Riflette le limitazioni della nostra società e certo anche nostre, però è anche pieno delle possibilità che sono in ognuno di noi.
(gli autori) |
|
| Critica (2): | Solanas e il cinema didattico
MOLTI VIETNAM
"Ogni spettatore è un vigliacco o un traditore". F. Fanon (e Solar)
Analisi e proposta, si dice nel nostri documenti sul "cinema a servizio della rivoluzione", ed ecco nella gran confusione di Pesaro il primo film politico che sappia trascurare dilemmi estetici e servirsi di un metodo marxista di analisi e proposta (ricerca attiva di una oggettività rivoluzionaria, quella della lotta di classe, contro tutte le deformazioni e le evasioni borghesi). Esso ci ricorda la necessità dialettica di un terzo (cronologicamento secondo) momento.
All’analisi – violenta, precisa, demistificatrice, settaria, secca come un colpo di fucile – della realtà dell’oppressione e delle sue diverse forme (dirette le une, indirette quanto quotidiane le altre), Solanas e Getino fanno seguire il momento più lento, e scavato sulla base di documenti tutti da inventare perché questa è storia non scritta e neppure prevista dal sistema, del riconoscimento di sé, della riconquista di sé e del proprio compito, da parte dell’oppresso. Ciò fatto, e solo a questo punto, il film-atto potrà passare infine alla proposta e precisarne i caratteri, poiché oramai il nemico (il bersaglio) e il nuovo agente (il fucile; e dei film l’autore vero e non solo il destinatario) sono stati definiti, e il resto deve essere manuale, indicazione pratica del come, bigino sull’uso delle armi.
La percussione lucida del primo momento – quello del riflettore a raggi X, e insieme del rifiuto dell’operazione di igiene mentale (rivoluzionaria) – ha il compito di riconoscere la realtà oltre il limitato obiettivo dell’esperienza individuale, di ricollocare questa in una totalità, di scoprire le fila nascoste del potere che condiziona ogni atto pur minimo e perfino reazioni inconscie, assuefazioni scontate; ha il compito di "spiegare la violenza" e far chiara l’assoluta necessità di una risposta violenta. Per quest’azione, il regista-militante si serve di tutti i mezzi che gli sembrano via via più utili ai fini dell’efficacia politica.
Non si addentra nelle spiegazioni minuziose e nei distinguo della socio-politica, così spesso male usati: la verità è abbastanza chiara da permettergli di non soffermarsi ai perticolari, anzi: ogni particolare, deve rimandare al tutto, al contesto generale e alla tesi politica. (Solanas ha fatto il suo tirocinio nel cinema pubblicitario: scandalizzeremo qualcuno affermando che è stato un bene? Sa che deve "vendere" al pubblico un prodotto altissimamente qualificato – la rivoluzione – per il quale, come per i grandi e complessi macchinari moderni dei capitale, è inutile cercare di condizionare l’acquirente con le suggestioni inconscie, e serve solo l’esatta descrizione del meccanismo e dei vantaggi che esso offre rispetto ad altri: ma questo discorso ci porterebbe lontani, e soprattutto ad una carenza del film, provvisoria, e sulla quale sarà comunque il caso di tornare: la proposta più chiara del socialismo che si propone, della non-macchina alternativa).
La seconda parte, posto sul tappeto il quadro generale di riferimento, deve cercare e rivolgersi al motore del cambiamento possibile, al protagonista della rivoluzione nella situazione specifica in cui il film intende operare: in questo caso la classe operaia argentina, o meglio: la classe operaia peronista. Solanas ora "deve" indulgere nel particolare, per rifare la storia da un punto di vista operaio, perché il destinatario del film si riconosca, scopra se stesso ed il suo posto. I suoi grandi momenti e quelli neri, i suoi successi e i suoi errori. L’intervista assume un ruolo essenziale il cui uso è nuovo perché nuova è la sua funzione; nell’operaio sullo schermo, l’operaio spettatore si riconosce attore. (Per il pubblico di Pesaro, forse il momento maggiore di chiarificazione politica rappresentato dal film è quello appunto della sua visione "peronista di sinistra", che lo ha costretto a rivedere il senso stesso di certi termini e la loro differenza di significato, tra qui, in un paese del blocco colonizzatore, e là, e a meglio rendersi conto delle sue complicità coloniali, delle sue inconscie (ma non troppo) pregiudiziali coloniali. D’altronde, la visione primaria e volgare della storia argentina, e particolarmente del peronismo, e più ancora del peronismo di oggi, senza Perón, è già stata ampiamente ridimensionata dai teorici e dai rivoluzionari sud-americani, e se la sinistra italiana lo ignora è colpa sua e del PCI).
Analizzati i limiti del peronismo, le insufficienze della spontaneità, i problemi della clandestinità, Solanas e Getino interrompono il film per il secondo grande intervallo, ed aprono il dibattito col loro pubblico, perché questi sia ancora di più attore e non consumatore. E siamo alla terza parte, che interviene basandosi soprattutto sull’esperienza dei militanti, sulla loro azione, la loro riflessione e le loro testimonianze in rapporto alla "violenza come forza di liberazione". Si ritorna al primo momento, ricchi degli apporti del secondo, da quello arricchiti o cresciuti. Ormai pienamente attore, il "pubblico" ha libertà d’intervento, di riflessione, di commento. È un discorso tra militanti, con le proposte precise di una linea fatte da alcuni di loro: i registi e il gruppo (la corrente politica) di cui essi fanno parte. Un "conto finale" sull’altra violenza, quella che lo spettatore-attore è chiamato a far sua come unica possibilità rivoluzionaria effettiva, e con precise proposte di organizzazione, chiude il film.
Ecco: è il film da noi teorizzato coi nostri documenti, come metodo e come forma. Ma naturalmente, affermando come noi facevamo che "un film politico vola quanto valgono le parole d’ordine che esso propone", su questo piano – nel pur generale entusiasmo, nel sempre entusiasmante incontro con altri che vede come noi – ogni discussione è aperta, all’interno della militanza. E su questo piano avanzeremmo una riserva. Comprendiamo perfettamente la linea "terzormondista" del film; la sua analisi ci sembra corretta. Eppure la sua visione dell’imperialismo è limitata da questo punto di vista. Il riferimento ad un contesto mondiale di organizzazione imperialista è generico, insufficiente. Temi non affrontati: la rivoluzione nei paesi "sviluppati", cioè nelle parti d’afflusso e non di saccheggio delle ricchezze, in un unico contesto organizzativo controllato da un unico imperialismo; il ruolo della classe operaia in questi paesi, e non solo il suo; un riferimento internazionale che inglobi i rapporti con l’imperialismo delle società sedicenti socialiste della sfera russa; la presenza di un paese rivoluzionario come la Cina. Non sono essenziali per la definizione della linea rivoluzionaria argentina? Non lo crediamo. In ogni modo, ne abbiamo avvertito la mancanza. Anche perché, ed è questa la lode maggiore che possiamo rivolgere a questo film nostro, si pone ormai con sempre maggiore urgenza la necessità di un cinema di questo genere anche da noi, o ancora meglio, di un film che, come La hora de los hornos fa per il "terzo mondo", spieghi e proponga a coloro che dovranno essere i protagonisti della rivoluzione qui il mondo delle società a capitalismo complesso in cui noi operiamo, e ricerchi con loro le vie rivoluzionarie necessarie e possibili. L’America Latina, dice Solanas, sarà il Vietnam degli anni settanta. Ma Detroit, Parigi, Berlino, ecc. hanno chiarito che i Vietnam sono possibili, forse indispensabili, anche nel cuore del sistema.
Goffredo Fofi, Ombre rosse n. 5 |
|
| Critica (3): |  |
|
| Critica (4): |  |
 | Fernando E. Solanas |
 |  |
|
 indica che il link è esterno al web comunale
indica che il link è esterno al web comunale
